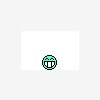C’era una volta un ragazzino di nove anni che stressava il papà perché lo portasse a pesca con lui. Ci riuscì un sabato pomeriggio, era il 10 maggio 1980.
Nella primavera di quell’anno, cominciarono ad apparire cose nuove nel seminterrato di casa: canne da pesca, barattoli del caffè con il tappo bucherellato e qualche mattina, prima di andare a scuola, uno spettacolo assolutamente nuovo nella stanza adibita a lavanderia e ripostiglio: una bacinella piena di pesci scuri, viscidi e limacciosi.
Erano pescigatto che mio padre pescava la sera nei fossi e canali della zona. Quell’anno gli venne la passione per la pesca, anzi, a sentire lui, gli tornò, perché da bambino diceva di andarci spesso e di portare sempre a casa la cena, sottoforma di pesci bianchi che poi la nonna provvedeva a friggere. Comunque sia, nella primavera di quell’anno che inaugurava il decennio dei personal computer, dei compact disk e delle canne da pesca in carbonio, per la prima volta avevo un pescatore in famiglia.
Dopo le mie ripetute insistenze, papà mi promise di portarmi il primo sabato libero. Lo seppi con un paio di giorni d'anticipo e non vedevo l'ora. Non sapevo nulla di pesci e pesca, se non che si usava una canna, una lenza e un verme per esca. Non avevo idea che si potessero usare altre esche, che ci fossero tanti tipi diversi di ami e lenze, e non conoscevo nemmeno i pesci, i loro nomi facevano parte delle tante parole apprese in famiglia, o al bar davanti casa, termini di uso comune che sottintendevano qualcosa che sapevo che esisteva, ma che non potevo riconoscere. Sapevo che esistevano le trote, ma di quelle avevo letto sui libri e sentito il nome alla tivvù, perché dalle nostre parti non ce n’erano, poi conoscevo le carpe e le “tenche”, i “luzi” (lucci), i “barbi” (pescigatto) e le “scardeve” (scardole). Stop. Mio papà possedeva 3 o 4 canne, tutte fisse. Una di 5 metri, rossa, in fibra, che a seconda delle esigenze accorciava a 4 o 3 metri semplicemente togliendo i vari segmenti telescopici facendoli passare uno dentro l'altro, le altre erano di bambù, una in tre pezzi ad innesti, di lunghezza attorno ai 3 metri e l’altra a pezzo unico, sempre di lunghezza simile, che per portarla in giro bisognava farla uscire dal finestrino del passeggero. In seguito di queste canne a pezzo unico arrivammo ad averne tre. Erano robustissime ma leggere. Quella in tre pezzi invece, aveva il vettino più morbido, abbastanza flessibile. Le montature erano da ABC della pesca: nylon bello grosso (almeno uno 0,30), sugherone, qualche piombo spaccato e amo bronzato grosso e robusto. Servivano per pescare i pescigatto e casomai le tinche che dividevano lo stesso habitat. Come esca sempre e solo i lombrichi, quelli grossi, lunghi e scuri che il papà e lo zio Fiorenzo catturavano a secchi infilando un lungo ferro nella terra umida degli orti, e poi collegandolo ad una presa di corrente. I vermi uscivano da soli e bastava raccoglierli e metterli nel secchio. Quel sabato pomeriggio c’era il sole. Mio papà venne a prendermi a scuola e mi confermò che saremmo andati a pesca. Mangiai in fretta, mi cambiai e ricordo che dissi a mio nonna che la sera avremmo mangiato il mio pesce. Fu una delle tante previsioni sbagliate della mia vita, ma sicuramente una delle meno importanti. Papà aveva un barattolo di caffè “suerte”, giallo ocra e marrone, con il tappo di plastica bucherellato, pieno di terra scura che, appena si toglieva il tappo, cominciava a muoversi: erano i vermoni che alla luce correvano più sotto possibile. “Ci vorrebbero i bigattini” mi disse “questi sono troppo grossi per te”. Ma il negozio di caccia e pesca non apriva prima delle tre e mezza e mio papà in mattinata non aveva fatto in tempo perché di solito, il sabato mattina (e la domenica), non si alzava mai prima di mezzogiorno. Così andammo nell’orto, in fondo al capannone dove il nonno allevava polli, e con una vanga riuscimmo a rimediare qualche vermicello striminzito che sarebbe andato meglio per le piccole scardole che, secondo papà, sarebbero state le mie prime prede. E lui con le previsioni, almeno quella volta, ebbe più fortuna di me.
Dopo aver messo le canne in auto, con quella lunga di bambù fuori dal finestrino della nostra ritmo color “arancio messico”, andammo da Umberto, detto “Bertino”, un cugino del papà che abitava a poche decine di metri da casa nostra. Bertino aveva una cannetta montata per prendere la minutaglia: me l’avrebbe prestata. Era una canna nera, con l’impugnatura bianca a righette rilevate antiscivolo, di marca “plufger”, 3,50 metri di lunghezza, naturalmente telescopica e in una fibra molto più bella di quella della canna rossa di papà: questa era lucida, levigata e brillante, l’altra era grezza e ruvida. Anche la lenza era diversa: mio papà avvolgeva semplicemente il filo attorno alla canna e andava a infilare l’amo in un grosso elastico di gomma nera, quella di Bertino, invece, usciva dal foro in fondo e poi veniva raccolta attorno ad un pezzo di plastica che aderiva alla canna ed era tenuto fermo da un elastico giallo. Il galleggiante era piccolo e affusolato, il filo sottile e l’amo talmente piccolo che finchè papà non srotolò del tutto la lenza, avevo il sospetto che non ci fosse.
Quella canna nera “plufger” divenne la mia prima canna. Bertino non la volle più indietro e devo ricordarmi di ringraziarlo, un giorno o l’altro, perchè non ricordo di averlo mai fatto.
Il posto prescelto si chiamava “tre ponti” e ci volevano dieci minuti di auto per arrivarci. Si chiamava così perché c’erano tre canali che scorrevano paralleli e passavano sotto la strada. Il più grande, quello centrale, si chiamava Molinella, quello a destra non mi ricordo di aver mai sentito che avesse un nome, mentre quello a sinistra, dove buttai per la prima volta la mia lenza, si chiamava Angòra, e adesso non c’è più, fagocitato qualche anno dopo dall’espansione artificiale del Molinella. C’erano molte auto e parecchie gente che pescava. Io ero eccitato e non vedevo l’ora di prendere il mio primo pesce. Papà parcheggiò, scaricammo la roba, e mentre ci avvicinavamo al canale mi ripetè più volte che dovevo stare fermo, avere pazienza e, soprattutto, non dovevo tirare su e giù la lenza continuamente. L’Angòra era un canale di medie dimensioni, almeno se rapportato a quelli presenti in zona, largo dai 5 agli 8 metri, con una profondità media di un metro e mezzo, corrente lenta e acqua non limpida ma nemmeno torbida, “l’importante” diceva papà “è che non si veda il fondo, altrimenti i barbi mangiano solo di notte”. Seguivo con attenzione ogni suo movimento mentre srotolava le lenze e provava il fondo per sistemare il galleggiantone, poi prendeva un super-verme dal barattolo di caffè e lo infilava sull’amo: chissà che male, povero verme! Ma il peggio doveva ancora venire, perché sull’amo il verme non ci stava tutto, e allora papà, stringendolo tra il pollice e l’indice, lo tagliava e infilava il pezzo in esubero su un altro amo sempre della stessa lenza. Le montature da gatti, infatti, finivano spesso con due ami. Dopo aver messo in acqua due canne, finalmente, toccò alla mia! Sistemata la profondità e infilato un pezzetto di un vermetto dell’orto, papà appoggiò la lenza in acqua e il galleggiantino si raddrizzò iniziando a camminare pian piano spinto dalla corrente. I galleggianti delle altre canne, invece, rimanevano coricati di lato e fermi. Papà mi spiegò che erano così perché pescavano “a cul” che non voleva dire “a fortuna”, ma “sul fondo”. Presi la canna con due mani e cominciai a seguire il galleggiante, prima con lo sguardo, poi camminandoci dietro, ogni tanto si muoveva e io avevo un guizzo, stringevo di più la canna ed ero pronto a tirare, ma papà mi diceva di aspettare: non erano pesci, ma le erbe del fondo che ogni tanto frenavano la lenza. “Non devi camminare” mi disse papà “così spaventi i pesci. Quando la lenza si ferma devi tirare su e ricominciare.” Feci così parecchie volte finchè, alla fine dell’ennesima passata senza sussulti, alzando la canna, sentii una leggera resistenza e mi trovai un gioiello argentato attaccato all’amo! Era il mio primo pesce, una piccola scardola con la coda rossa: bellissima!!! “È buona per la cena?” chiesi a papà. “Si, ma devi prenderne tante!” Non ne presi tante, soltanto altre due, praticamente fotocopie a colori della prima, ed entrambe si suicidarono, perché non riuscivo a capire quando mangiavano e quando dovevo ferrare, semplicemente me le ritrovai attaccate all’amo. Sotto questo aspetto, il primo vero pesce che pigliai coscientemente, ferrando quando il galleggiantino era sceso sotto il pelo dell’acqua, fu l’ultimo di quella giornata: un piccolo pescegatto scurissimo che papà mi intimò di non toccare. Non lo toccai ma non capivo cosa poteva farmi, certo era bruttino, ma non mi sembrava pericoloso, o forse era uno di quei pesci che ti danno la scossa? Ne avevo sentito parlare in tivvù ma non sapevo che ce ne fossero anche da noi. Papà mi spiegò che il pescegatto aveva tre spine: due ai lati e una sopra la schiena, bisognava stare molto attenti, soprattutto con gli esemplari più piccoli che li avevano più affilati. Dopo aver staccato il pesce papà mosse il galleggiante, facendolo scorrere di qualche centimetro verso l’alto: “così provi più a fondo” mi disse. Ma si dimenticò di dirmi che probabilmente la lenza non sarebbe più scesa in modo fluido, e infatti il galleggiante ad un trattò si fermò e andò sotto, come aveva fatto poco prima il pescegatto. Tirai ma non c’era nulla, solo che la lenza andò a sbattere contro la canna e si ingarbugliò in modo impressionante. “Ma io non ho fatto nulla! Ho solo tirato su.” Mio papà non si arrabbiò, anche se un po’ si innervosì, ma non tanto perché avevo tirato troppo forte ed avevo fatto il guaio, quanto per il fatto che non aveva nessun ricambio con se’ e, in ogni caso, non era ancora capace di sistemare bene le montature: di solito gliele faceva Antonio, l'amico pescatore con cui andava a pesca la sera.
Comunque il nostro pomeriggio di pesca finì con soli tre pesci, solo tre perché papà, incurante delle mie proteste, ributtò in acqua il gattino. Lui non prese nulla, ma ogni tanto si lamentava perché tirava su le lenze con gli ami resi lucidi da qualche pesce che si pappava i vermi senza attaccarsi. “Sono pesciolini” diceva, e io non capivo perché preferissero i super-vermi di papà ai miei teneri vermicelli. Nel frattempo, a qualche metro da noi, verso valle, si era sistemato un altro pescatore che aveva delle canna da fantascienza, lucide, colorate, e con un coso attaccato sotto, dotato di una manovella che, quando veniva girata, faceva un ronzio strano. Pescava senza galleggiante e quando la sua lenza entrava in acqua si sentiva uno “splash” che, secondo me, avrebbe allontanato senz’altro i pesci. Queste canne bellissime venivano posizionate dentro tubi di ferro conficcati nel terreno, così stavano belle dritte, con le punte verso il cielo. La cosa che mi stupì maggiormente fu però il contenuto di un barattolo di vetro, di quelli che si chiudevano a pressione: era pieno di mais, e il collega pescatore che papà sembrava conoscere, attaccava i chicchi sull’amo! Forse pescava anatre, pensai. Papà arrotolò le nostre canne, la pescata era finita, saremmo tornati un’altra volta, regalò i super-vermi al signore che, poco dopo, prese in mano una delle canne ferrando con forza. Ero curioso di vedere cosa avesse mangiato quel mais. “Ti serve una mano col guadino?” chiese papà, ma il signore gli disse che, no, non gli serviva, non era una carpa ma “un scardevon rompibale” e infatti tirò fuori di peso una grossa scardola, uguale a quelle piccole che ancora stavano nel sacchettino di carta marrone, quello che ogni giorno mia nonna portava a casa dalla bottega del “gigi”, dove faceva la spesa. Uguale come forma, ma non come misura, quella che il signore poi ributtò non troppo gentilmente in acqua era molto più grossa e non aveva le pinne rosse.
Tornando all’auto incrociammo un altro pescatore che pescava in Molinella. Aveva un retino di ferro sul fianco, tenuto a tracolla con uno spesso spago bianco. Papà forse conosceva anche lui perché si fermò a parlare. Nel retino c’erano tanti pesci, alcuni piccoli, altri più grossi. Erano “scardeve, varoni e aole” e il signore pescava con i famigerati bigattini che vidi per la prima volta, piccoli esseri indaffaratissimi a muoversi l’uno sull’altro, tutti colorati, ce n’erano di gialli, rossi, arancione e bianchi. “Ci vogliono questi per far divertire il bambino”, disse il signore a papà. “Alzati prima sabato, papà!” gli dissi io. Con rammarico, perché credevo che a casa poi nessuno avrebbe creduto che qualche pesce, comunque, l’avevo preso, papà regalò le tre scardolette al pescatore. Poi ci sedemmo in auto e ripartimmo verso casa. Lungo quella strada che solcava una campagna piatta e infinita tempestai di domande papà: che canne erano quelle del signore a cui aveva regalato i vermi? E poi perché glieli aveva regalati? E con il mais cosa si pescava? E i bigattini, quando me li avrebbe comprati? E quei pesci, i varoni e le aole, come facevo a distinguerli dalle scardeve? Ecco, ormai ero contagiato, la malattia era entrata in circolo. Ed era una malattia irreversibile.

















.gif)